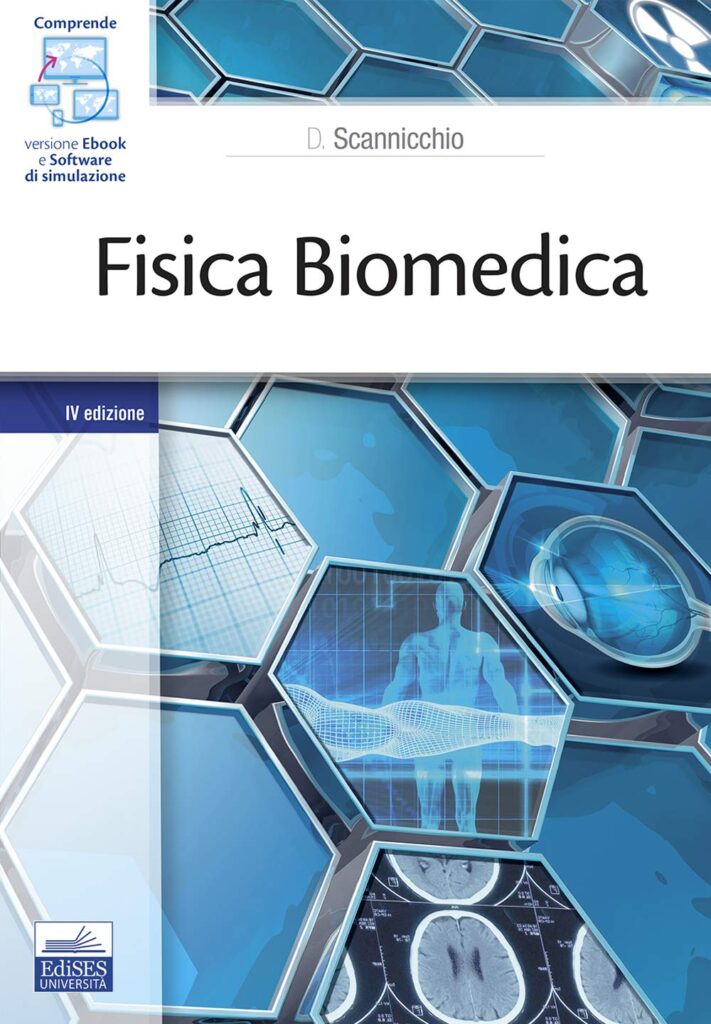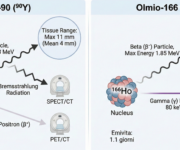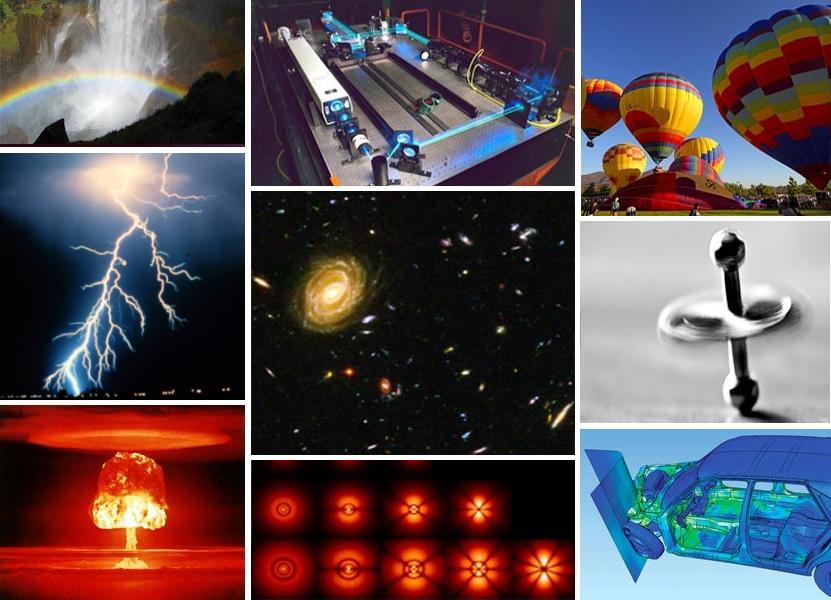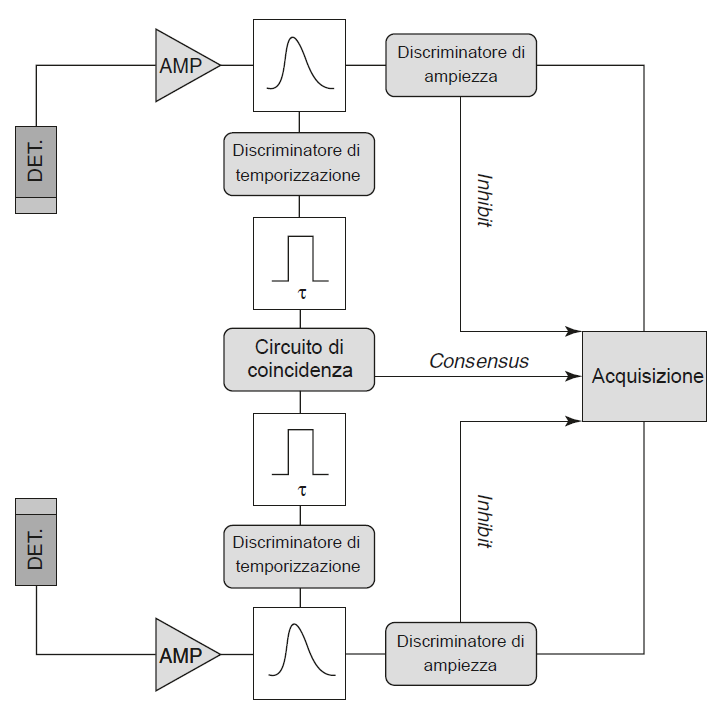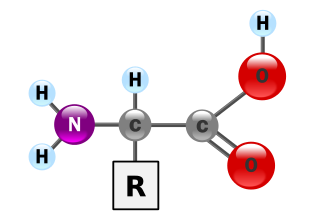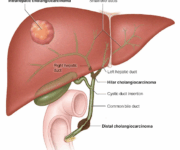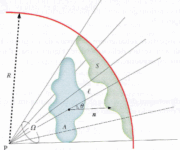Per effettuare la misura di una grandezza fisica, è necessario scegliere un’unità di misura omogenea rispetto alla grandezza da misurare. In linea di principio, si potrebbe introdurre un’unità di misura specifica per ogni tipo di grandezza fisica. Tuttavia, questo approccio risulterebbe poco pratico e, fortunatamente, non è necessario.
Infatti, tutte le grandezze fisiche possono essere espresse come combinazioni di un numero limitato di grandezze fondamentali. Di conseguenza, scegliendo le unità di misura per queste grandezze fondamentali, si può costruire un sistema di unità di misura, che consente di definire in modo coerente anche le unità delle grandezze derivate.
Il sistema attualmente adottato a livello internazionale è il Sistema Internazionale di unità di misura (abbreviato SI), ufficializzato in Italia con il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802. In ambito della meccanica, il SI assume come unità fondamentali:
- metro (m) per la lunghezza;
- chilogrammo (kg) per la massa;
- secondo (s) per il tempo.
Nonostante il SI sia lo standard internazionale, in alcuni contesti specifici, per esempio in determinati ambiti della Meccanica, si utilizzano ancora sistemi alternativi, scelti per la loro maggiore praticità in particolari applicazioni. Tra questi, uno dei più comuni è il sistema CGS, che utilizza:
- centimetro (cm) per la lunghezza;
- grammo (g) per la massa;
- secondo (s) per il tempo.
Now loading…
La seguente tabella riporta un confronto tra le unità fondamentali e alcune unità derivate nei sistemi SI e CGS.
| Grandezza | S.I. | C.G.S. | Sistemi pratici |
|---|---|---|---|
| GRANDEZZE FONDAMENTALI | | | |
| Massa | chilogrammo | grammo | grammomolecola |
| Lunghezza | metro | centimetro | ångström |
| Tempo | secondo | secondo | minuto, ora |
| Corrente elettrica | ampere | – | – |
| | | | |
| GRANDEZZE DERIVATE | | | |
| Volume | m³ | cm³ | litro |
| Densità | kg·m⁻³ | g·cm⁻³ | – |
| Forza | kg·m·s⁻² (newton) | g·cm·s⁻² (dyna) | kgpeso |
| Velocità | m·s⁻¹ | cm·s⁻¹ | mm·s⁻¹, km/h |
| Pressione | N·m⁻² (pascal) | dyna·cm⁻² (baria) | atmosfera, mmHg, cmH₂O |
| Lavoro, energia, calore | kg·m²·s⁻² (joule) | g·cm²·s⁻² (erg) | caloria, Caloria |
| Carica elettrica | s·ampere (coulomb) | u.e.s. | – |
Va inoltre sottolineato che in alcune discipline, come la Biofisica, vengono impiegate unità di misura che non appartengono né al SI né al CGS. L’uso di queste unità è spesso giustificato da motivazioni di ordine pratico: esse risultano più adatte a descrivere in modo immediato e significativo i fenomeni osservati. Alcuni esempi di tali unità “pratiche” sono riportati nella terza colonna.
In ogni caso, quando si eseguono calcoli che coinvolgono più grandezze fisiche, è fondamentale convertire tutte le unità in un unico sistema coerente (preferibilmente il SI), al fine di evitare errori e garantire l’affidabilità dei risultati.
Nello studio dell’Elettromagnetismo si incontrano proprietà della materia che non possono essere espresse tramite grandezze definibili esclusivamente in funzione delle tre grandezze fondamentali della Meccanica (lunghezza, massa, tempo).
Si presenta dunque la necessità di ampliare il sistema di riferimento, introducendo nuove grandezze fondamentali oppure fissando il valore di specifiche costanti di proporzionalità che compaiono nelle leggi fisiche che collegano le grandezze meccaniche a quelle elettromagnetiche.
Nel Sistema Internazionale (SI), per ovviare a questa esigenza, si introduce una quarta grandezza fondamentale: la corrente elettrica, la cui unità di misura è l’ampere (A).
L’ampere è definito come la corrente elettrica che, mantenuta in due conduttori paralleli, rettilinei, di lunghezza infinita e sezione circolare trascurabile, posti alla distanza di un metro l’uno dall’altro nel vuoto, genera una forza di 2 × 10⁻⁷ newton per metro di lunghezza tra i conduttori.
Nel Sistema Internazionale, alcune unità derivate di natura elettrica comunemente utilizzate includono:
- coulomb (C) per la carica elettrica;
- volt (V) per la differenza di potenziale;
- ohm (Ω) per la resistenza elettrica;
- tesla (T) per l’induzione magnetica;
- weber (Wb) per il flusso magnetico.
Va ricordato che in altri sistemi di unità di misura, si può scegliere una diversa grandezza elettrica fondamentale. Ad esempio, nel sistema CGS elettrostatico, invece della corrente elettrica, si assume come grandezza fondamentale la costante dielettrica del vuoto.
Di conseguenza, le unità di misura e le dimensioni delle grandezze elettriche variano nei diversi sistemi, e non sono sempre direttamente confrontabili.
Nella successiva tabella sono forniti fattori di conversione tra sistemi diversi di unità.
| Grandezza fisica | Conversione |
|---|---|
| Lunghezze | 1 micron (µm) = 10⁻⁴ cm |
| 1 ångström (Å) = 10⁻⁸ cm | |
| Volumi | 1 litro (L) = 1000 cm³ |
| Forze | 1 dyne = 10⁻⁵ newton (N) |
| Pressioni | 1 torr (1 mmHg) = 133.3 N/m² |
| 1 atm = 760 torr = 1.013 × 10⁵ N/m² = 1.013 × 10⁶ dyne/cm² | |
| Lavoro / Energia | 1 erg = 10⁻⁷ joule (J) |
| 1 caloria (cal) = 4.18 J | |
| 1 kilowattora (kWh) = 3.6 × 10⁶ J | |
| Potenza | 1 cavallo vapore (thp) = 735 watt (W) |
| Densità | 1 g/cm³ = 1000 kg/m³ |
| Concentrazione | 1 g/L = 10⁻³ g/cm³ |
| Velocità angolare | 1 giro/s = 2π rad/s ≈ 6.28 rad/s |
| Flusso (portata) | 1 litro/min = 16.6 cm³/s |
Nelle relazioni della Fisica si incontrano frequentemente quantità fisiche che assumono un valore costante. Tali costanti possono essere di natura diversa, ma sono tutte fondamentali per la descrizione dei fenomeni naturali.
Le costanti fisiche possono essere:
- numeri puri, cioè privi di dimensione. Un esempio tipico è il numero di Avogadro (NA), che indica il numero di atomi o molecole contenuti in una mole (grammo-molecola) di una sostanza. Il suo valore è circa 6,022 × 10²³;
- quantità dimensionali, cioè dotate di unità di misura. Questa categoria è la più frequente e comprende costanti che:
- rappresentano grandezze fisiche fondamentali, come la velocità della luce nel vuoto (c) o la massa dell’elettrone (me) e del protone (mp);
- esprimono valori associati a fenomeni fisici specifici, come la costante di Faraday (F), che rappresenta la quantità di carica elettrica contenuta in un grammo-ione di ioni monovalenti, ed è strettamente legata ai processi elettrochimici.
Esistono poi costanti fondamentali che assumono un significato ancora più profondo e universale. Tra queste:
- la costante di gravitazione universale (G), che interviene nelle leggi che regolano l’interazione gravitazionale tra corpi dotati di massa;
- la costante di Planck (h), centrale nella Meccanica Quantistica, che stabilisce la scala delle interazioni microscopiche e il comportamento quantizzato dell’energia.
Queste costanti non si limitano a descrivere fenomeni specifici, ma definiscono scale caratteristiche dell’Universo, sia su scala macroscopica (come G), sia microscopica (come h).
Nella successiva tabella sono riportati i valori di alcune delle costanti fisiche fondamentali più importanti.
| Costante fisica | Simbolo | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| Velocità della luce nel vuoto | c | 3.00 × 10⁸ | m/s |
| Carica elettrica dell’elettrone | e | 1.60 × 10⁻¹⁹ | C (coulomb) |
| Massa dell’elettrone | mₑ | 9.11 × 10⁻³¹ | kg |
| Massa del protone | mₚ | 1.67 × 10⁻²⁷ | kg |
| Costante di Planck | h | 6.63 × 10⁻³⁴ | J·s |
| Numero di Avogadro | Nₐ | 6.02 × 10²³ | mol⁻¹ |
| Costante dei gas perfetti | R | 8.31 | J·K⁻¹·mol⁻¹ |
| 0.082 | L·atm·K⁻¹·mol⁻¹ | ||
| Costante di Boltzmann | k | 1.38 × 10⁻²³ | J·K⁻¹ |
| Costante di Faraday | F | 96 487 | C·mol⁻¹ |
| Costante dielettrica del vuoto | ε₀ | 8.85 × 10⁻¹² | C²·N⁻¹·m⁻² |
| Costante gravitazionale universale | G | 6.67 × 10⁻¹¹ | N·m²·kg⁻² |
| Permeabilità magnetica del vuoto | μ₀ | 1.26 × 10⁻⁶ | N·A⁻² (o kg·m·C⁻²) |
| Costante di Stefan-Boltzmann | σ | 5.67 × 10⁻⁸ | W·m⁻²·K⁻⁴ |
| Costante di Wien | b | 2.897 × 10⁻³ | m·K |
| Equivalente meccanico della caloria | J | 4.18 | J/cal |
Fonte: Fisica biomedica.